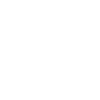ADHD: oltre l’attenzione. La neurobiologia della regolazione prefrontale

pubblicato il 12 ottobre 2025
Introduzione
Per molto tempo l’ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività) è stato interpretato come un semplice “problema di attenzione”.
Tuttavia, le ricerche neuroscientifiche degli ultimi due decenni hanno radicalmente cambiato prospettiva: oggi sappiamo che l’ADHD non è un disturbo dell’attenzione in sé, ma della regolazione cerebrale. A essere compromesso non è solo il “focus” attentivo, ma l’intero sistema che lo governa: la corteccia prefrontale e i suoi circuiti con i gangli della base, il cervelletto e la rete della salienza.
Queste aree, insieme, formano un complesso sistema di orchestrazione cognitiva che dirige l’attenzione, controlla gli impulsi, modula le emozioni e permette di mantenere uno stato mentale coerente con gli obiettivi del momento.
La corteccia prefrontale: il direttore dell’orchestra cognitiva
La corteccia prefrontale (PFC) è la regione cerebrale deputata al controllo “top-down”: seleziona le informazioni rilevanti, sopprime le distrazioni e mantiene la concentrazione su un obiettivo.
Quando questa funzione di controllo si indebolisce — come accade nell’ADHD — emergono i tipici sintomi di distraibilità, disorganizzazione e difficoltà di persistenza attentiva. In queste condizioni, le reti “bottom-up”, guidate dagli stimoli esterni, diventano dominanti. Il cervello ADHD tende a orientarsi verso ciò che è saliente, non necessariamente verso ciò che è importante.
Questo spiega perché un rumore, una notifica o un pensiero improvviso possano distogliere l’attenzione anche da un compito significativo.
La competizione bottom-up: quando vince lo stimolo
I circuiti “bottom-up” rispondono alla salienza: movimento, novità, intensità sensoriale o ricompensa.
Nell’ADHD, la regolazione prefrontale indebolita fa sì che questi input abbiano un peso maggiore nella selezione attentiva. Il cervello è così costantemente attratto da stimoli nuovi e gratificanti, con difficoltà a mantenere un’attenzione sostenuta su attività prive di immediato interesse o ricompensa.
È un meccanismo neurobiologico, non una mancanza di volontà: le reti dopaminergiche e noradrenergiche che modulano la motivazione e la concentrazione funzionano in modo alterato, riducendo la capacità di filtrare e organizzare gli stimoli in base alle priorità.
Regolazione emotiva e motivazione
La disregolazione nell’ADHD non si limita alla sfera cognitiva, ma coinvolge anche quella emotiva.
La corteccia prefrontale ventromediale (vmPFC), che normalmente regola le connessioni con l’amigdala, l’ipotalamo e i centri della ricompensa del tronco encefalico, risulta meno attiva. Questo comporta una minore capacità di modulare gli impulsi emotivi e un aumento della reattività. La persona con ADHD può sperimentare:
- bassa tolleranza alla frustrazione,
- cambiamenti rapidi dell’umore,
- difficoltà nel gestire la rabbia o l’entusiasmo.
Si tratta di una disregolazione affettiva, oggi riconosciuta come parte integrante del disturbo, e non come una semplice comorbidità.
Inibizione comportamentale: il “freno” del cervello
La corteccia prefrontale inferiore destra è essenziale per l’inibizione delle risposte automatiche.
Attraverso proiezioni verso i gangli della base e il cervelletto, questa regione permette di bloccare o ritardare risposte motorie e verbali inappropriate. Quando questo circuito è disfunzionale, la persona fatica a “fermarsi prima di agire” — da qui l’impulsività tipica dell’ADHD.
Non si tratta solo di iperattività motoria, ma anche di difficoltà nel trattenere parole, decisioni o comportamenti senza riflettere sulle conseguenze.
Dopamina, noradrenalina e la curva a U rovesciata
L’efficienza della corteccia prefrontale dipende dal giusto equilibrio dei neurotrasmettitori dopamina e noradrenalina, che agiscono rispettivamente sui recettori D1 e α2A.
Come ha mostrato Amy Arnsten (Yale University), l’attività di questi recettori segue una curva a U rovesciata:
- Quando l’attività catecolaminergica è troppo bassa → la PFC diventa inefficiente → distrazione, impulsività, disorganizzazione.
- Quando è troppo alta → la PFC si “blocca” → rigidità cognitiva, ansia e ipercontrollo.
L’obiettivo dei trattamenti farmacologici è quindi ristabilire un tono neurochimico ottimale, che permetta al cervello di operare nella cosiddetta “zona Goldilocks” — né troppo, né troppo poco.
Trattamento farmacologico e regolazione prefrontale
Gli stimolanti (come metilfenidato e anfetamine) e i non stimolanti (come atomoxetina e guanfacina) agiscono proprio su questi circuiti, aumentando in modo mirato la disponibilità di dopamina e noradrenalina nella corteccia prefrontale. In questo modo migliorano:
- il controllo attentivo top-down,
- la stabilità emotiva,
- la capacità di pianificazione,
- la resistenza alla distrazione.
Quando associato a psicoterapia, interventi psicoeducativi e comportamentali, il trattamento farmacologico non “cambia la personalità”, ma riporta il cervello alla sua condizione di equilibrio funzionale.
Contesto evolutivo e variabilità dei sintomi
La corteccia prefrontale è l’ultima area a completare la sua maturazione — spesso fino ai 25 anni.
Questo spiega perché i sintomi dell’ADHD evolvono nel tempo: nell’infanzia prevale l’iperattività, nell’adolescenza l’impulsività, e in età adulta la disorganizzazione e la fatica nel mantenere il focus. Anche lo stress, la privazione di sonno o i cambiamenti ormonali possono temporaneamente ridurre l’efficienza della PFC, rendendo più evidenti i sintomi in soggetti predisposti.
ADHD come disturbo della regolazione
Alla luce delle attuali conoscenze, l’ADHD può essere descritto come un disturbo della regolazione più che dell’attenzione.
È una condizione in cui contesto, stato di attivazione e neurochimica interagiscono costantemente, determinando fluttuazioni nella capacità di concentrazione, controllo e stabilità emotiva.
Un approccio terapeutico efficace non si limita a ridurre i sintomi, ma mira a stabilizzare il funzionamento della corteccia prefrontale, integrando:
- Precisione farmacologica,
- Psicoterapia
- Interventi comportamentali,
- Routine stabili e sonno regolare,
- Strategie di autoregolazione basate sulla consapevolezza e sulla pianificazione.
Conclusione
L’ADHD non è una questione di “mancanza di volontà” né un semplice “problema di attenzione”.
È un disturbo complesso che riflette un collasso temporaneo dell’orchestrazione corticale, in cui le reti prefrontali perdono la capacità di guidare efficacemente i processi attentivi, emotivi e motivazionali.
Capire l’ADHD in termini di neurobiologia della regolazione permette di superare pregiudizi e semplificazioni, e di personalizzare i trattamenti in base ai reali meccanismi cerebrali coinvolti.
Restituire alla persona il controllo sulla propria mente significa, in ultima analisi, ripristinare la capacità di autoregolarsi, non solo di “prestare attenzione”.
Dott. Charbel Farah - Psicologo
Bibliografia
- Arnsten, A. F. T. (2009). Stress signalling pathways that impair prefrontal cortex structure and function. Nature Reviews Neuroscience, 10, 410–422.
- Arnsten, A. F. T. (2011). Catecholamine influences on dorsolateral prefrontal cortical networks. Biological Psychiatry, 69, e89–e99.
- Castellanos, F. X., & Proal, E. (2012). Large-scale brain systems in ADHD: Beyond the prefrontal–striatal model. Trends in Cognitive Sciences, 16, 17–26.
- Cortese, S. (2020). The neurobiology and genetics of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): What every clinician should know. European Journal of Paediatric Neurology, 24, 5–14.
- Rubia, K. (2018). Cognitive neuroscience of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and its clinical translation. Frontiers in Human Neuroscience, 12, 100.
- Shaw, P., et al. (2010). Development of cortical surface area and thickness in ADHD. Biological Psychiatry, 67, 656–664.
- Sonuga-Barke, E. J. S. (2005). Causal models of ADHD: From inhibition to delay aversion. Biological Psychiatry, 57, 1231–1238.