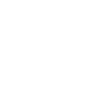Perché continuiamo a scrollare? Meccanismi neuroscientifici e psicologici del comportamento digitale compulsivo
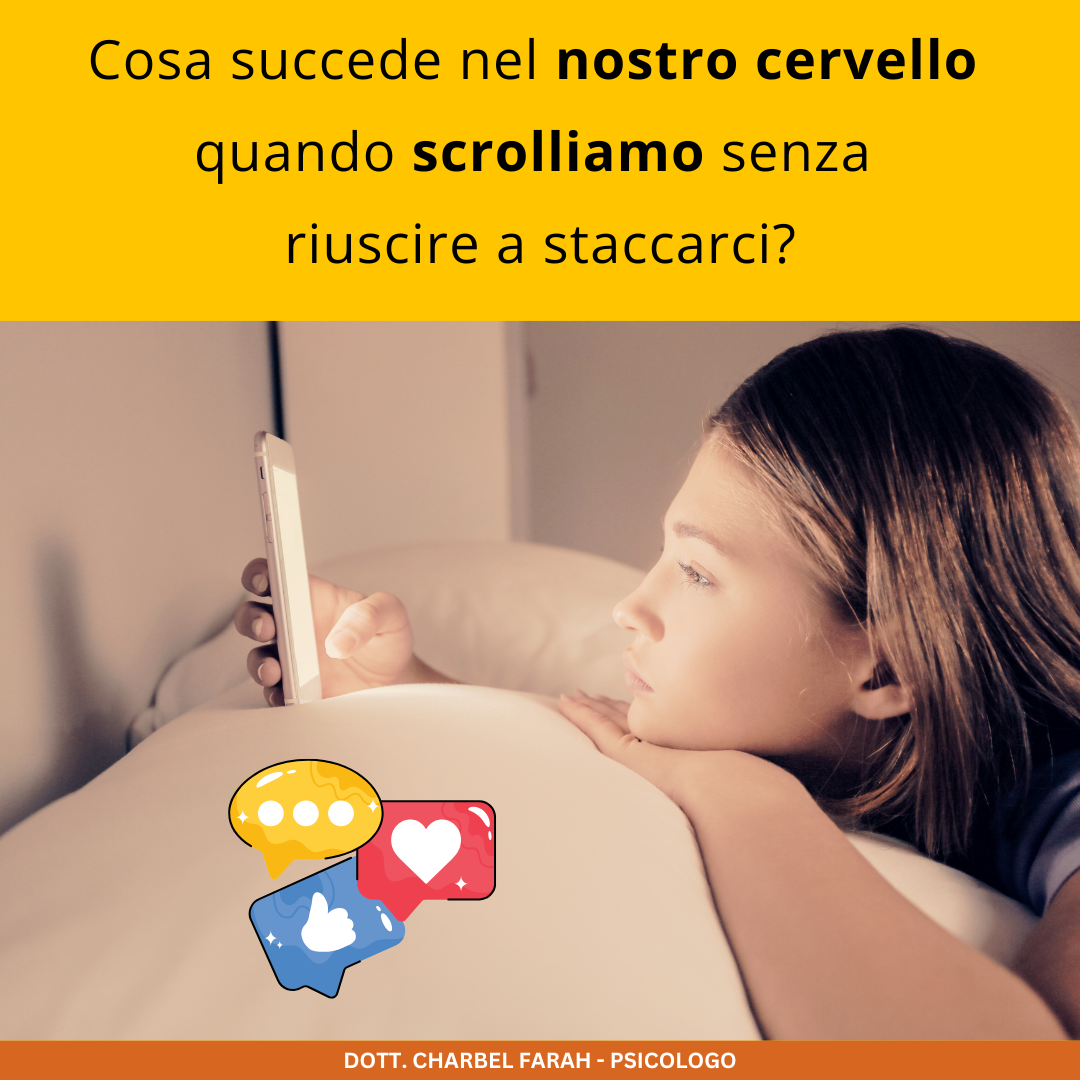
pubblicato il 01 luglio 2025
Introduzione
Scrollare il feed dei social network è diventato un gesto abituale e apparentemente innocuo. Eppure, quante volte ci accorgiamo che sono passati minuti — o interi quarti d’ora — mentre scorrevamo video, storie, post e reel, spesso senza un vero scopo?
Questo comportamento, noto anche come doomscrolling o infinite scrolling, non è semplicemente una cattiva abitudine: è radicato in meccanismi neuropsicologici profondi, legati alla motivazione, alla gratificazione, all’attenzione e alla regolazione delle emozioni.
L’obiettivo di questo articolo è esplorare in chiave scientifico-divulgativa cosa accade nel cervello quando scrolliamo, e perché questo comportamento è così difficile da interrompere.
Per farlo, analizzeremo sia i processi neurobiologici, sia i meccanismi psicologici e comportamentali coinvolti.
1. Meccanismi neuroscientifici: il cervello in cerca di stimoli
1.1 Il sistema della ricompensa e la dopamina
Il comportamento di scrolling attiva il circuito della ricompensa, in particolare la via mesolimbica dopaminergica, che coinvolge strutture come l’area tegmentale ventrale (VTA), il nucleo accumbens, e la corteccia prefrontale. Questo circuito è lo stesso che si attiva in risposta a stimoli primari come cibo, sesso e socialità.
I social media sfruttano il principio della ricompensa variabile: non sappiamo cosa apparirà al prossimo scroll — può essere un contenuto irrilevante o qualcosa che ci colpisce profondamente. Questa imprevedibilità massimizza la produzione di dopamina, rendendo il comportamento più resistente all’estinzione, proprio come accade nelle slot machine (Zald & Treadway, 2017).
1.2 Il cervello predittivo e il prediction error
La teoria del cervello predittivo suggerisce che il nostro sistema nervoso centrale non si limita a rispondere agli stimoli, ma anticipa costantemente cosa accadrà.
Quando il contenuto visualizzato è diverso da quello atteso, si genera un prediction error, che a sua volta stimola l’attività dopaminergica (Schultz, 1998).
Il feed dei social è progettato per fornire continue “sorprese” che mantengono alto il livello di attenzione e motivazione. In altre parole, il cervello "impara" che vale la pena continuare a scrollare, perché potrebbe arrivare qualcosa di interessante.
1.3 Attenzione esogena e sovraccarico sensoriale
Le piattaforme digitali utilizzano strategie di design attentivo per catturare l’attenzione esogena: notifiche, colori vivaci, suoni, movimento rapido. Questo sistema, evolutivamente utile per reagire a pericoli ambientali, viene oggi sfruttato per mantenere l’utente connesso.
Contemporaneamente, si riduce l’attivazione delle aree deputate al controllo attentivo volontario — in particolare la dorsolateral prefrontal cortex — compromettendo la capacità di interrompere l’azione e decidere consapevolmente di fermarsi (Rothbart, 2011).
2. Meccanismi psicologici: apprendimento, emozioni, abitudini
2.1 Condizionamento operante
Secondo la teoria del condizionamento operante (Skinner, 1953), i comportamenti che vengono rinforzati tendono a ripetersi. Scrollare il feed è rinforzato:
- Positivamente: quando troviamo contenuti che ci piacciono o ci intrattengono.
- Negativamente: quando ci aiuta ad evitare noia, ansia o momenti di vuoto.
Questo crea una catena comportamentale appresa, che si consolida nel tempo e può diventare automatica.
2.2 Evitamento emotivo e Coping passivo
Spesso, l’uso compulsivo dei social è una risposta a stati emotivi difficili: stress, insicurezza, solitudine. In psicologia si parla di Coping evitante: una strategia per non affrontare l’emozione, ma distrarsi da essa.
Anche se può portare sollievo momentaneo, nel lungo periodo può mantenere o intensificare il disagio emotivo sottostante, riducendo la nostra capacità di stare in contatto con i vissuti interni (Kardefelt-Winther, 2014).
2.3 Illusione di controllo
Il gesto del “pull-to-refresh” — tirare giù per aggiornare il feed — attiva una illusione di controllo (Langer, 1975): sembra che siamo noi a scegliere cosa vedere, ma in realtà stiamo reagendo a un sistema predittivo basato su algoritmi. Questa illusione rinforza la sensazione di agency, ma contribuisce al mantenimento del comportamento automatico.
2.4 FOMO e attaccamento digitale
La FOMO (Fear of Missing Out) è il timore di perdersi esperienze rilevanti vissute da altri. È un costrutto che ha radici evolutive: essere esclusi da un gruppo, un tempo, poteva rappresentare un rischio per la sopravvivenza.
Oggi si manifesta nel bisogno di controllare frequentemente il feed per non “restare indietro”. Questo alimenta l’attaccamento digitale, un legame costante con il dispositivo e con il mondo online (Przybylski et al., 2013).
3. Un comportamento evolutivo in un contesto digitale
Tutti questi meccanismi non sono “sbagliati”. Sono evolutivamente adattivi: il nostro cervello è progettato per esplorare, apprendere, cercare stimoli e mantenere connessioni sociali.
Solo che oggi lo facciamo in ambienti digitalmente iperstimolanti, progettati per sfruttare questi stessi meccanismi in modo continuativo. L’effetto non è necessariamente “patologico”, ma può diventare disfunzionale se ostacola la regolazione del tempo, delle emozioni e della concentrazione.
Conclusioni
Scrollare continuamente non è una semplice “cattiva abitudine”: è il risultato dell’attivazione di sistemi neurobiologici e psicologici sofisticati, che oggi vengono stimolati artificialmente in modo costante.
Essere consapevoli di come funziona il nostro cervello in questi contesti è il primo passo per recuperare il controllo sul nostro tempo, sulle nostre emozioni e sulla qualità della nostra attenzione.
L’obiettivo non è eliminare i social, ma usare consapevolmente strumenti che ci accompagnano ogni giorno, riconoscendo i meccanismi che li rendono così coinvolgenti.
Dott. Charbel Farah - Psicologo
Riferimenti
- Schultz, W. (1998). Predictive reward signal of dopamine neurons. Journal of Neurophysiology.
- Zald, D. H., & Treadway, M. T. (2017). Reward Processing, Neuroeconomics, and Psychopathology. Annual Review of Clinical Psychology.
- Skinner, B. F. (1953). Science and Human Behavior.
- Kardefelt-Winther, D. (2014). A conceptual and methodological critique of internet addiction research. Addiction Research & Theory.
- Langer, E. J. (1975). The illusion of control. Journal of Personality and Social Psychology.
- Przybylski, A. K., et al. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Computers in Human Behavior.
- Rothbart, M. K. (2011). Becoming Who We Are: Temperament and Personality in Development.