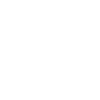Squid Game 2 (2024) - Recensione Psicologica
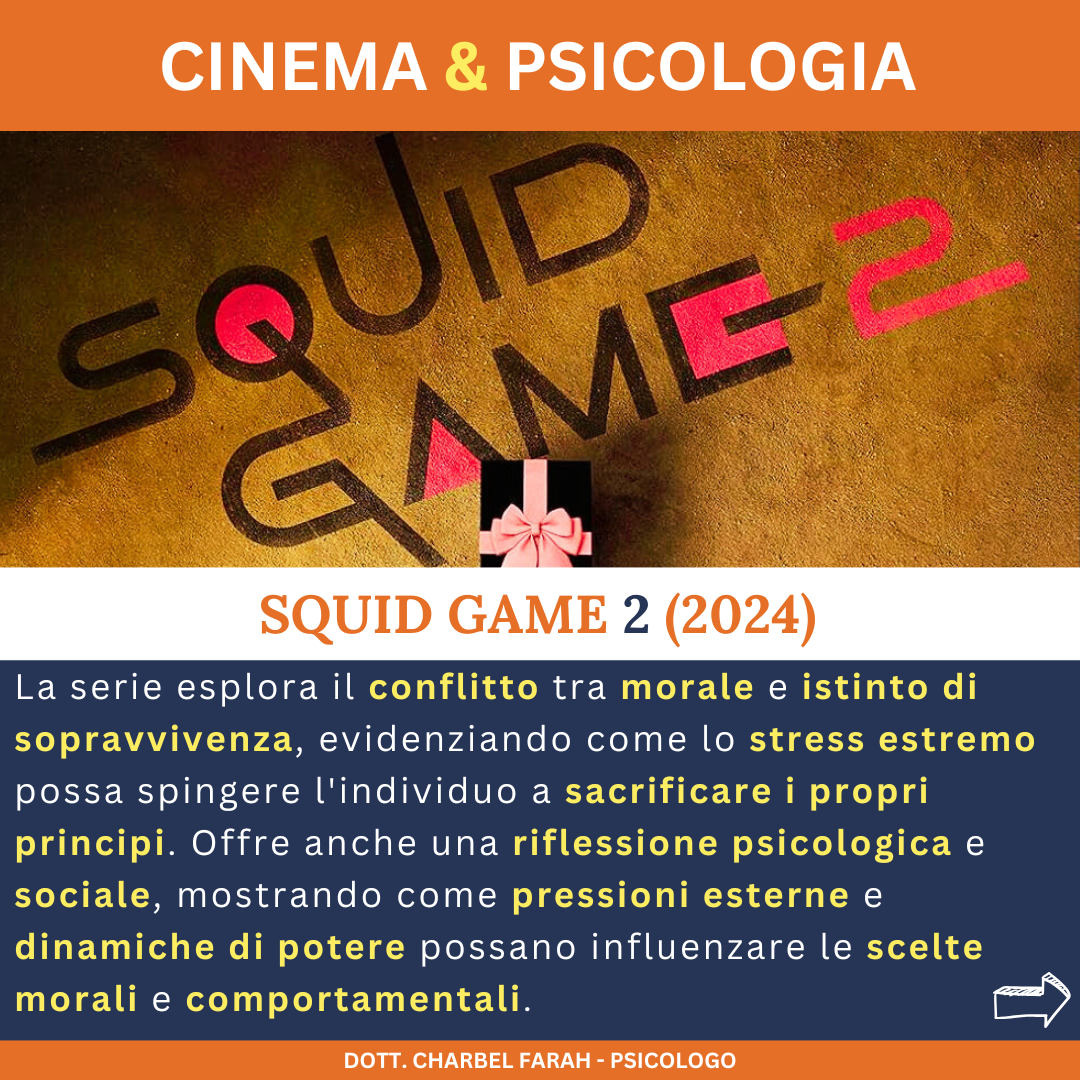
❗SPOILER ALERT❗
La seconda stagione della serie Sudcoreana Squid Game era attesissima, con i fan di tutto il mondo curiosi di scoprire come il racconto avrebbe evoluto le vicende e approfondito le tematiche introdotte nella prima stagione.
La serie esplora il conflitto tra morale e istinto di sopravvivenza, evidenziando come lo stress estremo possa spingere l'individuo a sacrificare i propri principi. Offre anche una riflessione psicologica e sociale, mostrando come pressioni esterne e dinamiche di potere possano influenzare le scelte morali e comportamentali.
PSICOLOGIA SOCIALE
Dal punto di vista della psicologia sociale, la seconda stagione di Squid Game offre molti spunti di riflessione. Le dinamiche di gruppo e i comportamenti individuali sotto pressione sono analizzati attraverso lenti di numerosi modelli e teorie.
1. Il CONFORMISMO DI ASCH
È una teoria che spiega come gli individui siano inclini a seguire le opinioni o i comportamenti del gruppo, anche quando questi vanno contro le proprie convinzioni personali.
| Nell'esperimento sul conformismo di Solomon Asch, ai partecipanti veniva chiesto di confrontare la lunghezza di una linea con altre tre e indicare quale fosse della stessa lunghezza. In ogni sessione, solo uno era il vero partecipante, mentre gli altri (complici) davano deliberatamente risposte sbagliate in alcune prove. Asch osservò che, nonostante la risposta corretta fosse evidente, circa il 75% dei partecipanti si conformava almeno una volta all'opinione errata del gruppo, dimostrando l'influenza della pressione sociale sulle decisioni individuali. |
L'ipotesi del conformismo di Asch può essere osservata in diverse situazioni della serie, personaggi e scene che mettono in luce il modo in cui i partecipanti al gioco si adeguano al comportamento del gruppo anche quando questo contrasta con il loro giudizio personale.
- Il momento delle votazioni per continuare o interrompere il gioco: In una delle scene iniziali, i partecipanti devono decidere collettivamente se proseguire con il gioco o abbandonarlo. In questa situazione, alcuni personaggi esitano a prendere una posizione personale e finiscono per conformarsi alla maggioranza, nonostante le loro preoccupazioni o paure interiori.
- La scelta di alleanze strategiche: Quando i giocatori si organizzano in squadre per affrontare le prove, alcuni di loro si uniscono a gruppi che percepiscono come più forti, anche se queste alleanze non rispecchiano i loro valori o preferenze. Questo comportamento evidenzia il desiderio di appartenenza e il timore dell'isolamento, dinamiche centrali negli esperimenti di Asch.
Queste situazioni rivelano come la pressione sociale e il desiderio di evitare il conflitto o l'esclusione possano influenzare profondamente le decisioni dei personaggi, soprattutto in un contesto di estrema competizione e sopravvivenza.
2. La TEORIA DELLA SCELTA RAZIONALE
Propone che le persone prendano decisioni basandosi su un calcolo dei costi e benefici per massimizzare il proprio interesse. Nella serie, questo si traduce in partecipanti che valutano costantemente se cooperare o competere, spesso scegliendo in base a ciò che offre loro la maggiore possibilità di sopravvivenza. Per esempio, molti personaggi si trovano a dover bilanciare il rischio di tradire gli altri con il possibile vantaggio personale. Un tema centrale è il modo in cui le nostre scelte vengono influenzatedalle offerte che ci vengono presentate. Gli organizzatori del gioco manipolano i partecipanti offrendo opzioni apparentemente libere, ma strategicamente progettate per guidare le loro decisioni. Questo solleva il quesito sulla vera indipendenza delle scelte: siamo davvero liberi o agiamo secondo una falsa indipendenza?
3. La TEORIA DELLA PERSUASIONE DI CIALDINI
Analizza i meccanismi attraverso cui le persone vengono spinte a compiere determinate scelte. Tra i sei principi fondamentali individuati da Cialdini, quelli della reciprocità e della scarsità (delle risorse) emergono chiaramente:
- La reciprocità si manifesta quando i personaggi sono portati a cooperare o aiutarsi a vicenda con l’aspettativa implicita di ricevere un beneficio futuro, anche se il contesto non garantisce alcuna sicurezza.
- La scarsità (risorse limitate), invece, è evidente nelle limitazioni imposte dagli organizzatori: premi esclusivi, risorse scarse o opportunità uniche vengono offerte ai giocatori in modo tale da creare un senso di urgenza e desiderio, che spesso sovrasta il loro giudizio razionale. Ad esempio, nelle sfide finali, i partecipanti sono posti di fronte a scelte dove la possibilità di vincita è estremamente limitata. Questo non solo li spinge a lottare con maggiore intensità, ma genera anche conflitti interni, come il dilemma tra mantenere l’integrità morale e sfruttare l’occasione unica di prevalere. La percezione che "non ci sarà un’altra possibilità" amplifica l’intensità delle emozioni e guida decisioni altrimenti improbabili.
4. TEORIA DEL COSTO E BENEFICIO
Quanto l’uomo è disposto a sacrificare per raggiungere i propri obiettivi?
Questo tema si lega alla "teoria del Costo-Beneficio", che suggerisce come le persone valutino le loro azioni in termini di guadagni personali.
Tuttavia, il sacrificio personale non è sempre legato al guadagno individuale; ci sono momenti in cui i personaggi si trovano a scegliere tra il proprio interesse e il benessere altrui.
La tensione tra altruismo e egoismo emerge chiaramente, mostrando come la pressione estrema possa portare le persone a tradire i loro valori morali.
Esempi concreti di queste dinamiche si trovano nei momenti in cui i partecipanti devono collaborare per superare le sfide. Ad esempio, le alleanze temporanee che si formano e si dissolvono evidenziano come la fiducia reciproca sia fragile e condizionata dalla percezione di utilità immediata.
5. La TEORIA DEL DILEMMA DEL PRIGIONIERO
È un problema della teoria dei giochi che illustra come due individui razionali, agendo nel proprio interesse personale e senza possibilità di comunicare, possano arrivare a un risultato peggiore rispetto a quello ottenibile collaborando.
Nella sua forma classica, il dilemma rappresenta una situazione in cui entrambi i giocatori devono scegliere tra due opzioni: cooperare o tradire.
La scelta razionale per ciascun individuo è tradire, ma se entrambi lo fanno, il risultato complessivo è meno vantaggioso rispetto alla cooperazione reciproca.
Analogamente, i giocatori nella serie sono continuamente spinti a valutare se fidarsi degli altri o scegliere una strada egoistica per massimizzare le proprie probabilità di successo.
Il dilemma del prigioniero è un esperimento teorico della teoria dei giochi che illustra come due individui razionali, che agiscono per il proprio interesse, possano finire in una situazione peggiore rispetto a quella che avrebbero ottenuto collaborando. Scenario classicoDue prigionieri sono accusati di un crimine. Viene offerta loro la seguente scelta, senza che possano comunicare tra loro:
|
PERCHÉ I GIOCATORI NON SCELGONO DI ANDARE VIA ABBANDONANDO IL GIOCO?
I giocatori di Squid Game non riescono a scegliere di uscire e salvarsi per diversi motivi psicologici e sociali, che sono sapientemente sfruttati dagli organizzatori del gioco. Ecco alcune delle ragioni principali, espresse in base a dinamiche della serie:
- Illusione del Controllo
Gli organizzatori creano un ambiente in cui i partecipanti sentono di avere una certa influenza sul proprio destino, anche se questa è in gran parte un’illusione. La possibilità di vincere una ricompensa straordinaria li fa credere di poter "controllare" la situazione attraverso le proprie capacità, ignorando che le condizioni sono fortemente manipolate. - Effetto della Scarsità (Risorsa Limitata)
Come evidenziato in precedenza, la scarsità gioca un ruolo cruciale. L’enorme premio in denaro rappresenta una risorsa limitata, e i partecipanti sono motivati a continuare per evitare di perdere la loro "unica opportunità". Questo senso di urgenza sovrasta la loro capacità di valutare i rischi reali di rimanere. - Dissonanza Cognitiva
Una volta che i giocatori iniziano a partecipare, si trovano a giustificare le proprie azioni per ridurre il disagio emotivo derivante dalla violenza e dalla competizione. Questo fenomeno di dissonanza cognitiva li porta a convincersi che la scelta di restare sia giustificata, anche se moralmente o razionalmente discutibile. - Norma della Reciprocità
La dinamica sociale del gioco incoraggia legami di reciprocità: chi ha ricevuto aiuto o protezione da altri si sente obbligato a restituire il favore, mantenendo così un certo grado di lealtà che scoraggia l’abbandono del gioco. - Effetto Sunk Cost
Più tempo e fatica un giocatore dedica al gioco, più difficile diventa per lui abbandonarlo. Questo effetto, noto come "costo irrecuperabile", è evidente quando i partecipanti scelgono di continuare a competere nonostante il rischio crescente, perché percepiscono di aver già "investito troppo" per tirarsi indietro. - Pressione del Gruppo e Conformismo
Il conformismo di Asch si manifesta anche qui: i giocatori sono meno inclini a uscire dal gioco se nessuno prende l’iniziativa di farlo, temendo il giudizio o l’isolamento sociale. La pressione collettiva li spinge a seguire il flusso piuttosto che agire individualmente. - Manipolazione Psicologica
Gli organizzatori sfruttano abilmente il contesto per alimentare speranze e paure. Le regole cambiano spesso per mantenere i partecipanti in uno stato di incertezza, e momenti di tregua apparente sono seguiti da situazioni di forte stress, manipolando le emozioni per renderli più docili e vulnerabili.
Queste dinamiche, combinate con il contesto di disperazione e il senso di disperata competizione, creano una trappola psicologica quasi insormontabile per i partecipanti, che li spinge a rimanere nonostante le opzioni apparentemente migliori.
NEUROSCIENZE E CONFERME SCIENTIFICHE
Le neuroscienze forniscono ulteriore supporto alle osservazioni sulla psicologia sociale evidenziate in questa stagione. Studi sul cervello mostrano come le scelte sotto pressione siano influenzate dall’attività delle aree limbiche, come l’amigdala, responsabile delle reazioni emotive, e la corteccia prefrontale, coinvolta nel processo decisionale razionale.
Nei momenti di alta tensione, l’amigdala tende a dominare, portando a decisioni impulsive o guidate dalla paura. Questo è ben rappresentato nelle scene in cui i personaggi reagiscono a stimoli immediati senza avere il tempo di valutare razionalmente le conseguenze.
Un altro elemento interessante è il ruolo della dopamina, il neurotrasmettitore associato al piacere e alla ricompensa. Gli organizzatori dei giochi manipolano abilmente questo sistema, creando situazioni in cui i partecipanti cercano costantemente di ottenere ricompense immediate o evitare punizioni.
Questa dinamica è coerente con i modelli neuroscientifici che spiegano la dipendenza e il comportamento compulsivo, suggerendo che i partecipanti non solo sono psicologicamente manipolati, ma anche biologicamente predisposti a rispondere in certi modi.
Infine, le neuroscienze supportano l’idea che la cooperazione e il tradimento siano influenzati da fattori biologici, come il rilascio di ossitocina, che favorisce la fiducia e la connessione, o il cortisolo, associato allo stress, che può erodere la capacità di cooperare.
Questi processi sottolineano come le decisioni dei personaggi non siano semplicemente il risultato di valutazioni razionali, ma di una complessa interazione tra mente e corpo.
DINAMICHE INTRAPERSONALI
Dal punto di vista intrapersonale, la seconda stagione affronta ancora una volta il conflitto interiore dei protagonisti: la lotta tra il mantenere la propria umanità e il cedere alla disumanità per sopravvivere. Tuttavia, anche qui, il tema risulta meno incisivo rispetto alla prima stagione, forse a causa della minore caratterizzazione di alcuni nuovi personaggi e di scelte narrative meno audaci.
RIFLESSIONI SULLA MORALE E L’ETICA IN SITUAZIONI ESTREME
La seconda stagione di Squid Game ci pone di fronte a interrogativi fondamentali riguardo alla natura della morale e dell'etica umana. Questi principi sono davvero radicati nel nostro essere o vengono applicati solo quando le circostanze lo permettono?
La serie offre uno specchio in cui osservare come gli individui siano disposti a rinunciare ai propri valori in situazioni di estrema difficoltà.
La competizione crudele e spietata dei giochi costringe i partecipanti a confrontarsi con le proprie convinzioni, rivelando quanto la sopravvivenza possa prevalere su regole morali considerate fondamentali in condizioni normali.
1. Morale e Etica come Principi Situazionali?
Le azioni dei giocatori suggeriscono che la morale e l'etica non sono sempre intrinseche e inamovibili, ma spesso si piegano alle necessità contingenti. Ad esempio, personaggi che inizialmente si mostrano altruisti o cooperativi si ritrovano a compiere atti egoistici o addirittura violenti per garantirsi la sopravvivenza. Questo mette in discussione la convinzione che i principi etici siano universali e immutabili, suggerendo piuttosto che possano essere adattati o abbandonati in risposta a pressioni esterne.
2. Giudicare gli Altri Senza Conoscerne le Circostanze
Un altro tema importante è la facilità con cui giudichiamo le azioni altrui senza comprendere le circostanze che le hanno generate. La serie invita lo spettatore a riflettere su quanto le scelte degli individui siano influenzate da fattori che non sono immediatamente visibili. Ad esempio, alcuni personaggi tradiscono i propri alleati o compiono azioni moralmente discutibili, ma il contesto estremo e le dinamiche di manipolazione rendono queste scelte comprensibili, sebbene non giustificabili. Questo spinge a un esercizio di empatia: come reagiremmo noi in situazioni simili?
3. La Crisi dei Valori in Situazioni Estreme
Trovandosi in condizioni di vita o di morte, i protagonisti della serie si scontrano con il dilemma di mantenere i propri principi o abbandonarli per sopravvivere. Questa crisi mette in evidenza come i valori etici e morali siano vulnerabili di fronte a una pressione estrema. Personaggi che sembrano incrollabili nella loro integrità iniziale cedono alla tentazione di proteggere se stessi a scapito degli altri, evidenziando la fragilità della moralità umana in condizioni di stress elevato.
4. Mette a Nudo il Pensare e l’Agire Umano
In definitiva, Squid Game offre uno spaccato crudo del comportamento umano, costringendo i personaggi – e il pubblico – a confrontarsi con domande scomode: fino a che punto siamo disposti a rinunciare ai nostri valori per sopravvivere? La serie mette in luce quanto sia sottile il confine tra giusto e sbagliato, mostrando che, in situazioni estreme, il pensare e l’agire umano si svelano in tutta la loro complessità e contraddittorietà.
LA PSICOLOGIA EVOLUTIVA
Diversi psicologi hanno esplorato la questione di come le regole morali possano essere influenzate o sovrastate dalla necessità di sopravvivenza, specialmente in situazioni estreme. Il tema riguarda soprattutto la psicologia evolutiva e la psicologia sociale.
- Un esempio celebre riguarda lo psicologo Abraham Maslow, che ha sviluppato la sua gerarchia dei bisogni. Secondo questa teoria, i bisogni di base, come la sicurezza e la sopravvivenza, devono essere soddisfatti prima che una persona possa concentrarsi su bisogni più elevati, come l'autorealizzazione o la moralità.
- In situazioni di estremo pericolo, ad esempio, un individuo potrebbe ignorare o violare le regole morali pur di garantire la propria sopravvivenza.
- Un altro riferimento importante potrebbe essere il paradosso morale esplorato da psicologi come Jean Piaget e Lawrence Kohlberg, i quali hanno studiato lo sviluppo morale nei bambini. Secondo il modello di Kohlberg, in condizioni di stress o emergenza, la moralità potrebbe essere "sospesa" o modificata a seconda delle circostanze. La sopravvivenza, in effetti, potrebbe diventare la motivazione primaria, portando gli individui a mettere da parte considerazioni morali qualora esse non siano più utili o addirittura dannose per il mantenimento della vita.
Le teorie evolutive suggeriscono che i comportamenti di sopravvivenza sono talmente radicati nella nostra psicologia che, in situazioni estreme, possono prendere il sopravvento sulla moralità codificata. I principi di altruismo o solidarietà potrebbero essere temporaneamente ignorati per cercare di garantire la propria vita, come nei casi di cannibalismo in situazioni di emergenza (ad esempio, nel famoso caso dei sopravvissuti al disastro aereo delle Ande nel 1972). Diversi psicologi, quindi, hanno esplorato come, in situazioni di emergenza o grave pericolo, il bisogno di sopravvivenza possa effettivamente prevalere sulle norme morali che, in circostanze normali, vengono seguite rigorosamente.
Squid Game, quindi può essere letta come una rappresentazione drammatica di come le teorie evolutive possano manifestarsi in situazioni estreme. Le scelte morali dei partecipanti sono costantemente messe alla prova in un ambiente in cui la sopravvivenza è la priorità, portando alla prevalenza, talvolta, di comportamenti egoistici che vanno contro i principi morali tradizionali. Questo rende la serie un potente riflesso delle dinamiche di sopravvivenza, competizione e cooperazione, che sono al centro della psicologia evolutiva e delle teorie darwiniane.
RITMO E NARRAZIONE
Uno degli aspetti che ho trovato meno riusciti è il ritmo narrativo. La stagione è più lenta rispetto alla prima, con episodi che spesso sembrano ripetitivi e privi di momenti realmente sorprendenti. Questo rallentamento influisce negativamente sull’immersione e sulla tensione, due elementi che avevano caratterizzato la prima stagione.
Inoltre, i nuovi elementi introdotti sono pochi e, in alcuni casi, appaiono strategicamente banali, come se fossero stati inseriti più per obbligo narrativo che per vera necessità creativa. Un esempio è la ribellione interna, che a prima vista risulta poco logica, poiché l’esito era chiaramente destinato al fallimento. Tuttavia, può essere interpretata come un atto disperato e morale, un tentativo di sabotare il gioco e rifiutare di continuare a uccidere, anche a costo della propria vita.
Allo stesso modo, la sottotrama di chi cercava l’isola via mare sembra essere stata abbandonata senza spiegazioni, ma potrebbe rappresentare un’apertura per la prossima stagione, suggerendo che ci siano ancora resistenze esterne o misteri da svelare. Nonostante queste potenziali intenzioni, l'esecuzione narrativa lascia comunque una sensazione di incompletezza.
Conclusione
In conclusione, la seconda stagione di Squid Game mantiene una rilevanza psicologica e sociale, esplorando il conflitto tra morale e istinto di sopravvivenza in un contesto di manipolazione e disumanizzazione. Tuttavia, non riesce a eguagliare l’intensità e l’originalità della prima stagione, lasciando un senso di incompiutezza e delusione.
Nonostante i difetti, rimane un’opera che invita a riflettere sul prezzo della sopravvivenza, sull’illusione della libertà di scelta e sulle dinamiche di potere che modellano i comportamenti umani, offrendo spunti di analisi profondi e attuali.
Il mio voto per la serie è 6️⃣.5️⃣ su 🔟
Dott. Charbel Farah - Psicologo