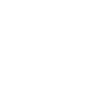Overthinking: quando pensare troppo diventa un problema (e cosa puoi fare)

pubblicato il 16 dicembre 2025
Ci sono momenti in cui la mente sembra non spegnersi mai. Una frase detta in fretta torna a galla ore dopo, una scelta rimane sospesa perché “manca ancora un dettaglio”, un messaggio visualizzato senza risposta diventa il centro di una ricostruzione infinita: “Cosa avrà pensato? Ho sbagliato tono? E se…?”.
È questo che molte persone chiamano overthinking: pensare troppo, in modo ripetitivo, senza riuscire a trovare un punto di arrivo. A prima vista può sembrare un difetto del carattere o un’abitudine “da eliminare”.
In realtà, nella maggior parte dei casi l’overthinking è un segnale: è la mente che prova a fare il suo lavoro di protezione, ma lo fa in un modo che, alla lunga, aumenta la sofferenza invece di ridurla. Capire cosa sta cercando di ottenere è spesso il primo passo per interrompere il circolo vizioso.
Che cos’è davvero l’overthinking
L’overthinking non è semplicemente riflettere. Riflettere è un processo utile: ti aiuta a mettere ordine, comprendere, prendere decisioni. L’overthinking, invece, assomiglia più a un “loop”: le stesse idee ritornano, si riformulano, cambiano forma, ma non portano a un’azione concreta né a un sollievo stabile. Anzi: più ci pensi, più aumenta l’attivazione emotiva e più la mente sente il bisogno di continuare a pensarci.
In clinica, questo fenomeno viene spesso collegato a due processi principali.
- Il primo è la preoccupazione, orientata al futuro: la mente anticipa scenari negativi e prova a prepararsi (“E se va male? E se succede qualcosa?”).
- Il secondo è il rimuginio, orientato al passato: il pensiero torna su ciò che è accaduto e cerca spiegazioni, colpe, alternative (“Perché l’ho fatto? Cosa avrei dovuto dire?”).
Pur essendo diversi, preoccupazione e rimuginio condividono un elemento: la convinzione implicita che pensare di più aiuterà a sentirsi più al sicuro.
1) La mente sta cercando di proteggerti
Una delle idee più importanti per comprendere l’overthinking è questa: spesso non nasce “senza motivo”. Nasce quando la mente percepisce un rischio. Non necessariamente un pericolo fisico, ma anche un rischio relazionale (rifiuto, giudizio), un rischio identitario (sentirsi incapaci, inadeguati), un rischio pratico (sbagliare una scelta) o un rischio emotivo (provare dolore, vergogna, perdita).
In questi casi il pensiero diventa uno strumento di controllo. È come se la mente dicesse: “Se analizzo abbastanza, troverò la soluzione. Se prevedo tutto, eviterò di soffrire.” Questo può dare un sollievo immediato, perché la sensazione di “stare pensando” somiglia alla sensazione di “stare facendo qualcosa”.
Ma il costo è alto: l’attivazione cresce, il corpo resta in allerta e il pensiero si intensifica.
Dal punto di vista della psicologia cognitiva e metacognitiva, l’overthinking è spesso sostenuto da credenze come: “Se mi preoccupo, mi preparo meglio”, “Se smetto di pensarci, significa che non mi importa”, “Se non controllo, accadrà qualcosa”.
Non sono idee “stupide”: sono tentativi comprensibili di protezione.
Però, quando diventano rigide, trasformano la mente in una centrale di allarme che non riesce a disattivarsi.
2) Il bisogno di certezze: quando l’incertezza pesa troppo
Un’altra radice frequente dell’overthinking è la difficoltà a tollerare l’incertezza. In molte persone l’ansia non nasce tanto dal “possibile evento negativo”, quanto dall’impossibilità di avere una garanzia.
La mente vuole certezze, e quando non le ottiene, aumenta i tentativi: controlla, anticipa, chiede conferme, rilegge, interpreta.
Questo meccanismo è particolarmente evidente nei momenti di transizione: un nuovo lavoro, una relazione che inizia (o finisce), una decisione economica, un cambiamento familiare, un esame, una diagnosi medica.
In questi contesti l’overthinking diventa una forma di “coperta mentale”: più la realtà appare instabile, più il pensiero prova a stabilizzarla. Il problema è che non sempre è possibile stabilizzare ciò che, per definizione, è incerto. E allora la mente non conclude mai: rilancia, riformula, ricomincia.
3) Ripassi la scena perché ti importa (non perché stai fallendo)
Quando l’overthinking riguarda una conversazione, un errore o un momento di imbarazzo, spesso dietro c’è un tema semplice e umano: quella cosa conta. Conta perché riguarda la tua reputazione, la tua appartenenza, la tua immagine, il tuo valore. In questi casi il loop mentale non è una prova di incapacità: è una prova di investimento.Il rischio, però, è che l’overthinking si trasformi in autocritica.
Il pensiero non si limita a rivedere l’episodio, ma costruisce una sentenza: “Ho sbagliato”, “Sono fatto così”, “Non sono all’altezza”. Qui il problema non è l’evento iniziale, ma la traiettoria che prende il pensiero: da analisi a condanna. E quando la mente si muove in questo modo, spesso aumenta l’evitamento: si rimanda una conversazione, si evitano situazioni sociali, si smette di esporsi. L’overthinking allora non è più solo un pensiero: diventa un comportamento di ritiro.
4) Quando la mente non si fida: l’overthinking nelle relazioni
In alcune persone l’overthinking è fortemente relazionale. Nasce dalla difficoltà a fidarsi del fatto che l’altro sia prevedibile, benevolo, stabile. Allora la mente “legge tra le righe” per prevenire il rischio: cerca micro-segnali, analizza tempi di risposta, interpreta sfumature, anticipa abbandoni o giudizi.
È un meccanismo che spesso ha una storia: esperienze di incoerenza affettiva, relazioni in cui la sicurezza non era garantita, momenti in cui essere ingenui è costato caro. In questi casi pensare troppo è un modo per proteggere la vulnerabilità. Il lavoro utile non consiste nel dirsi semplicemente “fidati”, ma nel costruire gradualmente una base più solida: confini chiari, comunicazione più diretta, capacità di tollerare la possibilità di non controllare l’altro, e soprattutto la possibilità di restare in contatto con sé anche quando l’altro delude.
5) Sovraccarico mentale: quando il sistema è troppo pieno
C’è poi un aspetto spesso sottovalutato: a volte l’overthinking è anche fatica cognitiva. Stress prolungato, mancanza di recupero, sonno irregolare, troppe richieste contemporanee, iperstimolazione digitale: tutto questo riduce le risorse mentali.
Quando il cervello è stanco, diventa più difficile interrompere un pensiero e riportare l’attenzione al presente. È come se l’interruttore dell’attenzione fosse meno efficiente.
In questi casi è importante non colpevolizzarsi: non è “mancanza di forza di volontà”. È un sistema che sta funzionando in modalità emergenza. E come ogni sistema in emergenza, tende a ripetersi e a semplificare: torna sugli stessi temi perché non ha energia per integrare davvero.
L’overthinking non è “buono”, ma è normale: cosa significa ascoltarlo senza farsi trascinare
Capire che l’overthinking è un segnale può far pensare: “Allora va bene così”. Non è questo il punto. Dire che è comprensibile non significa dire che è utile. L’obiettivo non è eliminare i pensieri, ma cambiare la relazione con essi: riconoscerli, comprenderne la funzione, e poi scegliere un intervento più efficace.
Una regola pratica, molto semplice, può aiutare: se il pensiero sta producendo chiarezza e azione, allora è riflessione. Se sta aumentando tensione e immobilità, allora è loop.
In quel momento l’intervento migliore raramente è “pensare ancora di più”.
È interrompere il circuito, regolare l’attivazione e riportare il pensiero su qualcosa di concreto.
Una strategia breve: ascolta, poi intervieni
Quando senti che la mente sta entrando in overthinking, prova a fare due passaggi.
- Il primo è riconoscere: “Sto rimuginando”, “Sto anticipando scenari”, “Sto cercando certezza”. Nominare il processo crea una piccola distanza: non sei il pensiero, stai avendo quel pensiero.
- Il secondo è scegliere l’intervento in base al tipo di problema. Se il problema è risolvibile, allora serve un passo di problem-solving: definire l’obiettivo, scegliere una micro-azione e farla. Se invece è un problema non risolvibile subito (o non controllabile), allora serve un intervento di regolazione: riportare il corpo a un livello di calma sufficiente per non alimentare il loop.
Cinque Tips concreti per calmare la mente e uscire dal loop
Quando sei nel pieno dell’overthinking, non servono grandi ragionamenti: servono strumenti brevi, ripetibili, realistici.
- Il primo è il respiro lento. Non perché “risolve” il problema, ma perché abbassa l’attivazione fisiologica che alimenta il loop. Anche solo uno o due minuti di espirazione più lunga dell’inspirazione possono aiutare.
- Il secondo è scrivere. Mettere su carta i pensieri spesso riduce la sensazione di caos e permette di separare ciò che è ipotesi da ciò che è fatto. La scrittura è utile anche perché ti costringe a rallentare e rende più evidente la ripetizione.
- Il terzo è tornare al presente attraverso i sensi. Quando la mente è nel futuro o nel passato, il corpo è spesso nel presente. Un piccolo grounding (osservare ciò che vedi, ascoltare suoni, sentire i piedi a terra) interrompe la fusione con il film mentale.
- Il quarto è darsi un limite. L’overthinking tende a occupare ogni spazio disponibile. Stabilire un “tempo dedicato” (anche solo 10–15 minuti) e rimandare fuori da quel tempo è un allenamento all’incertezza: non stai evitando, stai scegliendo quando e quanto.
- Il quinto è cambiare attività. Un’azione semplice e breve—una camminata, una doccia, una piccola attività domestica—può funzionare come “reset” dell’attenzione. Il punto non è distrarsi per scappare, ma interrompere l’iperattivazione per recuperare una mente più flessibile.
E se non basta? L’opzione di chiedere aiuto
A volte l’overthinking non si limita a essere un fastidio: interferisce con il sonno, con le relazioni, con le decisioni, con l’autostima. In questi casi può essere molto utile chiedere un supporto professionale. Non perché “c’è qualcosa che non va”, ma perché esistono strumenti specifici, validati e personalizzabili.
Approcci come la terapia cognitivo-comportamentale, la terapia metacognitiva e l’Acceptance and Commitment Therapy lavorano in modo mirato su preoccupazione, rimuginio, credenze sul pensiero e comportamenti di mantenimento (evitamento, rassicurazioni, controllo).
Il vantaggio di un percorso è imparare non solo cosa fare, ma quando farlo e perché funziona nel tuo caso specifico. Chiedere aiuto è spesso il gesto più concreto di cura: significa smettere di affrontare tutto da soli, e costruire un modo più sostenibile di stare con la propria mente.
Dott. Charbel Farah - Psicologo
Riferimenti
- Beck, J. S. (2011). Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond. Guilford Press.
- Wells, A. (2009). Metacognitive Therapy for Anxiety and Depression. Guilford Press.
- Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2012). Acceptance and Commitment Therapy: The Process and Practice of Mindful Change. Guilford Press.
- Nolen-Hoeksema, S. (2000). The role of rumination in depressive disorders and mixed anxiety/depressive symptoms. Journal of Abnormal Psychology.
- Borkovec, T. D., Robinson, E., Pruzinsky, T., & DePree, J. A. (1983). Preliminary exploration of worry: Some characteristics and processes. Behaviour Research and Therapy.